UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
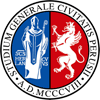
FACOLTA' DI Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
 Laurea triennale
- T068
- Chimica ambientale
Laurea triennale
- T068
- Chimica ambientale
Sede di Perugia
|
ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE |
| ANNO |
PERIODO |
DISCIPLINA |
DOCENTE |
ORE
TEOR. + PRAT. |
CFU |
| 3 |
II semestre
|
Chemiometria
|
Prof.
CLEMENTI
Sergio
|
48 + 0 |
6 |
| 2 |
II semestre
|
Chimica ambientale
|
Prof.
MURGIA
Sandro Maria
|
55 + 0 |
6 |
| 2 |
II semestre
|
Chimica analitica 2 - Elaborazione dati |
Prof.
CLEMENTI
Sergio
|
16 + 0 |
2 |
| 2 |
II semestre
|
Chimica analitica 2 - Laboratorio di chimica analitica |
Prof.
BELLACHIOMA
Gianfranco
|
32 + 30 |
6 |
| 2 |
II semestre
|
Chimica analitica 2 - Metodi spettroscopici in chimica analitica |
Dott.ssa
DEL GIACCO
Tiziana
|
32 + 0 |
4 |
| 3 |
I semestre
|
Chimica biologica
|
Prof.
PALMERINI
Carlo Alberto
|
48 + 0 |
6 |
| 3 |
II semestre
|
Chimica e merceologia degli alimenti
|
Prof.
BALESTRIERI
Fabrizio
|
48 + 0 |
6 |
| 2 |
I semestre
|
Chimica fisica
|
Dott.
ORTICA
Fausto
|
55 + 0 |
6 |
| 2 |
I semestre
|
Chimica fisica - Laboratorio di chimica fisica |
Dott.
ROMANI
Aldo
|
24 + 24 |
6 |
| 3 |
I semestre
|
Chimica fisica applicata
|
Prof.
ALOISI
Gian Gaetano
|
48 + 0 |
6 |
| 2 |
II semestre
|
Chimica informatica ambientale
|
Prof.
CRUCIANI
Gabriele
|
48 + 0 |
6 |
| 3 |
II semestre
|
Chimica inorganica applicata
|
Prof.
CROCCHIANTI
Stefano
|
48 + 0 |
6 |
| 2 |
I semestre
|
Chimica organica
|
Prof.ssa
PIERMATTI
Oriana
|
55 + 0 |
6 |
| 2 |
I semestre
|
Chimica organica - Laboratorio di chimica organica |
Prof.ssa
PIERMATTI
Oriana
|
31 + 45 |
6 |
| 3 |
I semestre
|
Chimica organica applicata - Aspetti chimici, applicazioni, riciclo di materiali polimerici |
Dott.ssa
MARROCCHI
Assunta
|
24 + 0 |
3 |
| 3 |
I semestre
|
Chimica organica applicata
|
Prof.
TATICCHI
Aldo
|
24 + 0 |
3 |
| 2 |
I semestre
|
Ecotossicologia
|
Dott.ssa
ELIA
Antonia Concetta
|
55 + 0 |
6 |
| 3 |
I semestre
|
Geochimica Applicata
|
Dott.
FRONDINI
Francesco
|
40 + 15 |
6 |
| 3 |
II semestre
|
Tecnologie chimiche per l'ambiente - Laboratorio di chimica ambientale |
Prof.
CLEMENTI
Sergio
|
32 + 30 |
6 |
| 3 |
II semestre
|
Tecnologie chimiche per l'ambiente
|
Prof.
POLETTI
Antonio
|
48 + 0 |
6 |
| 3 |
I semestre
|
Tecnologie di monitoraggio ambientale
|
Dott.
PROIETTI
Gabriele
|
48 + 0 |
6 |
|
PROGRAMMI DEI CORSI |
|
|
Chemiometria
|
|
(Docente:
Prof.
CLEMENTI
Sergio)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
Richiami di statistica tradizionale
. Analisi statistica multivariata. Metodi di classificazione e di regressione. Disegno statistico sperimentale.
Metodi di classificazione basati sulla distanza euclidea: analisi
discriminante, analisi cluster, KNN. Analisi delle componenti
principali (PCA). Il metodo SIMCA. Applicazioni del metodo SIMCA a
problemi complessi in campo alimentare (tipicità degli alimenti), in
campo farmaceutico (riconoscimento di droghe), in campo geologico
(classificazione di rocce o di petroli), ed in campo ambientale
(campionamento di acque marine o fluviali; emissioni da inceneritori di
rifiuti solidi urbani; fotodegradazione).
Metodi di regressione. Regressione lineare semplice e multipla.
Criteri per valutare la bontà del modello.Analisi delle variabili
latenti (PLS). Validazione dei modelli di regressione. I parametri SDEP
e Q2. Applicazioni di PLS in campo alimentare (qualità di alimenti in
funzione delle materie prime o di parametri di processo; controllo di
qualità di prodotti alimentari per via spettrale o per mezzo di analisi
multivariata dell'immagine; trattamento di dati sensoriali) ed
ambientale (relazione fra parametri chimici, biologici e climatologici;
conservazione di beni culturali). Modelli PLS con predittività
ottimale. La procedura GOLPE.
Controllo di processo. Strategie di ottimizzazione. Disegni
fattoriali, fattoriali frazionari, centrali composti. Disegni
D-ottimali. Superfici di responso. Studio delle superfici di responso.
La procedura CARSO. Responsi multipli (funzioni di desiderabilità).
Ottimizzazione di una reazione chimica. Lo spazio della reazione e lo
spazio sperimentale. Caratterizzazione multivariata di sistemi
discreti. Proprietà principali. Il metodo del simplesso. Esempi di
studi di ottimizzazione. |
| |
Modalità di Esame:
Esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Lun-Ven. 9.00-12.00
|
| |
Testi Consigliati:
Appunti del docente
|
|
|
Chimica ambientale
|
|
(Docente:
Prof.
MURGIA
Sandro Maria)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
1 Caratteristiche chimiche e fisiche dei comparti ambientali
L?atmosfera
L?idrofsera
La geosfera e il suolo
2) Inquinamento dell?atmosfera
Principali fonti di inquinamento naturali ed antropiche
Caratteristiche chimiche e fisiche degli inquinanti atmosferici
Inquinanti primari e loro effetti ambientali
Inquinanti secondari e loro formazione:
reazioni chimiche e fotochimiche
reazioni acido-base nell?atmosfera
reazioni dell?ossigeno, dell?azoto e dei composti azotati atmosferici
reazioni dell?ozono
inquinanti organici e loro reattività nell?atmosfera
Lo smog fotochimico
Le piogge acide
Distruzione dello strato di ozono stratosferico
Le particelle nell?atmosfera e loro formazione
Dispersione degli inquinanti nell?atmosfera, venti e stabilità atmosferica e inversioni termiche
Modelli di previsione per la dispersione degli inquinanti. Modello gaussiano
Esercitazioni in aula
3) Inquinamento dell?acqua
Principi di biochimica acquatica
Natura e classi di inquinanti delle acque
Inquinanti inorganici nell'acqua: metalli pesanti, metalloidi e ioni e loro comportamento chimico
Inquinanti e microinquinanti organici
I sedimenti, formazione e loro comportamento chimico nei corpi idrici
Inquinamento nei corsi fluviali e suoi principali effetti: deficit di ossigeno e curve a sacco
Fenomeni di eutrofizzazione cause e valutazione dello stato trofico di un bacino idrico
Esercitazioni in aula.
Impianti di trattamento delle risorse idriche. Descrizione dei
porocessi fisici, chimici e biologic di trattamentoi delle acque.
Processi di potabilizzazione delle acque per uso umano. Trattamento dei
fanghi di depurazione.
4) Inquinamento del suolo
Natura e principali fonti degli inquinanti del suolo
Inquinamento legato alle pratiche agricole
Inquinamento causato dai rifiuti
Comportamento chimico degli inquinanti nei suoli
5) Principi di analisi compartimentale
Principi chimico-fisici che regolano la dispersione delle sostanze nei comparti ambientali
Proprietà fluidometriche dei comparti ambientali
Modello della fugacità di McKay
|
| |
Modalità di Esame:
Esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Venerdì 9.00 - 13.00
|
| |
Testi Consigliati:
-Chimica dell'ambiente, di Stanley E. Manahan, Edizione italiana a cura
di Lelio Zoccolillo, Editore: Piccin Nuova Libraria S.p:A., Padova
-Ecologia Applicata, di Renato Vismara, Biblioteca Scientifica Hoepli,
Editore: Ulrico Hoepli S.p.A., Milano
Appunti di lezione
|
|
|
Chimica analitica 2 - Elaborazione dati |
|
(Docente:
Prof.
CLEMENTI
Sergio)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
Elaborazione dati
Richiami di statistica tradizionale. Media, varianza e deviazione
standard. Funzioni di distribuzione. Valori critici. Intervalli di
confidenza. Analisi di regressione ed analisi di correlazione. Analisi
di regressione lineare multipla. Multicollinearità. Cenni di analisi
statistica multivariata |
| |
Modalità di Esame:
Esame scritto ed orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Lun-Ven 9.00-12.00
|
| |
Testi Consigliati:
Appunti del docente
|
|
|
Chimica analitica 2 - Laboratorio di chimica analitica |
|
(Docente:
Prof.
BELLACHIOMA
Gianfranco)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
Chimica Analitica I
|
| |
Programma:
Cromatografia,aspetti teorici generali. Gascromatografia: strumentazione, colonne, iniettori,rivelatori GC/MS.
HPLC:strumentazione, colonne, iniettori rivelatori. Metodi di
analisi qualitativi e quantitativi, tecniche di preparazione del
campione, tecniche diiniezione selettiva.
AA: generalità. Termini spettroscopici. molteplicità.
Interpretazione fisica dei numeri quantici. Eccitazione termica.
Sorgenti a catodo cavo. autoassorbimento. Atomizzazione in fiamma ed in
fornetto, differenze dei due metodi. Bruciatori.
Sviluppo di un metodo di analisi, controllo qualitàcertificazione e legislazione.
|
| |
Modalità di Esame:
Esame scritto ed eventuale esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Martedì 10-12
|
| |
Testi Consigliati:
Consultare il docente
|
|
|
Chimica analitica 2 - Metodi spettroscopici in chimica analitica |
|
(Docente:
Dott.ssa
DEL GIACCO
Tiziana)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
richiede propedeuticità
|
| |
Programma:
1) Metodi analitici.
Classificazione dei metodi analitici. Metodi strumentali. Strumenti per l'analisi. La scelta del metodo
analitico. Sensibilità. Limite di rivelabilità. Selettività. Sorgenti di rumore nell'analisi strumentale.
Rapporto segnale/rumore.
2) Metodi spettroscopici.
Lo spettro elettromagnetico. Interazione tra radiazione e materia. Tecniche ottiche di analisi.
Spettroscopia di assorbimento e di emissione.
Spettrofotometria ultravioletta/visibile. Assorbimento
nell'UV/visibile. Origine del colore. Legge dell?assorbimento.
Strumentazione: sorgenti, selettori di lunghezza d'onda, rivelatori di
radiazione,
sistemi di lettura. Tipi di strumento. Contenitori del campione.
Spettrofotometria infrarossa. Assorbimento nell' IR. Vibrazioni molecolari. Spettri IR. Parametri
caratteristici delle bande. Strumentazione: spettrofotometri a dispersione e a trasformata di Fourier (FTIR).
Sistemi di preparazione del campione. Analisi in riflettanza.
|
| |
Modalità di Esame:
esame, prova scritta e orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
lunedì 11-13
|
| |
Testi Consigliati:
D.A.Skoog, J.J.Leary, Chimica analitica strumentale, Ed. EdiSES, Napoli. Dispense del docente.
|
|
|
Chimica biologica
|
|
(Docente:
Prof.
PALMERINI
Carlo Alberto)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
Chimica Organica
|
| |
Programma:
Organizzazione delle cellule procariotiche ed eucariotiche. Virus.
Amminoacidi e loro principali proprietà. Il legame peptidico.
Proteine: Funzioni e struttura. I livelli di strutturazione
proteica: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria: caratteristiche
chimiche ed implicazioni biologiche. In particolare: proteine globulari
e fibrose, collagene, cheratina, mioglobina ed emoglobina.
Emoglobina. Proprietà allosteriche
Enzimi: natura chimica e classificazione. Coenzimi e vitamine.
Cinetica della catalisi enzimatica. Regolazione dell'attività
enzimatica. Inibizione enzimatica.
Acidi nucleici. Basi azotate. Nucleosidi e nucleotidi. Struttura DNA ed RNA. Codice genetico.
Carboidrati: mono, oligo e polisaccaridi struttura e proprietà.
Lipidi. Trigliceridi, fosfolipidi colesterolo e suoi derivati. Lipidi delle membrane con aspetti funzionali.
Introduzione al metabolismo
Cinetica e termodinamica - Equilibri delle reazioni - Ciclo dell'ATP, ossidoriduzioni cellulari.
Catabolismo glicidico: glicolisi, neoglicogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi, fermentazione e metabolismo ossidativo.
Catabolismo lipidico: ossidazione degli acidi grassi e chetogenesi
Catabolismo delle proteine. Reazione di transamminazione e
deamminazione , ciclo dell'urea, aspetti metabolici degli scheletri
carboniosi: Amminoacidi glico e chetogenetici..
Metabolismo terminale: Il ciclo citrico.
Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa.
|
| |
Modalità di Esame:
Esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Lunedì 13-14; martedì 13-14,venerdì 11-13.
|
| |
Testi Consigliati:
L. Streyer Biochimica Zanichelli
A. Lehninger Principi di Biochimic Zanichelli (consultazione)
Note:
|
|
|
Chimica e merceologia degli alimenti
|
|
(Docente:
Prof.
BALESTRIERI
Fabrizio)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
|
| |
Modalità di Esame:
|
| |
Orario di Ricevimento:
|
| |
Testi Consigliati:
|
|
|
Chimica fisica
|
|
(Docente:
Dott.
ORTICA
Fausto)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
nessuna
|
| |
Programma:
Caratteristiche generali della spettroscopia, spettroscopia atomica,
spettroscopia molecolare: spettroscopie ottiche (rotazionale,
vibrazionale, rotovibrazionale, elettronica); tecniche basate sulla
diffusione (spettroscopia Raman); spettroscopie di risonanza (risonanza
magnetica nucleare, risonanza di spin elettronico). |
| |
Modalità di Esame:
esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Sempre a disposizione
|
| |
Testi Consigliati:
Rivolgersi al docente.
Sono anche disponibili delle dispense sintetiche del corso.
|
|
|
Chimica fisica - Laboratorio di chimica fisica |
|
(Docente:
Dott.
ROMANI
Aldo)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
Programma:
Le strumentazioni in spettroscopia:
atomica: lo spettrofotometro da assorbimento atomico e la strumentazione XRF
vibrazionale: lo spettrofotometro IR a dispersione e a trasformata di Fourier, lo spettrometro Raman.
elettronica: lo spettrofotometro UV-Vis-NIR in assorbimento, lo spettrofluorimetro, il colorimetro.
di risonanza: lo spettrometro NMR
Applicazioni delle varie spettroscopie con particolare riguardo alle problematiche ambientali.
Esercitazioni pratiche di laboratorio
|
| |
Modalità di Esame:
Relazioni di laboratorio ed esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Più o meno quando volete
|
| |
Testi Consigliati:
Skoog e Leary, Chimica analitica strumentale, Ed. EdiSes
|
|
|
Chimica fisica applicata
|
|
(Docente:
Prof.
ALOISI
Gian Gaetano)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
Programma:
Nozioni generali sulle radiazioni elettromagnetiche (natura, sorgenti,
monocromatori, rivelatori e attinometri chimici) e sulle
apparecchiature comuni nei laboratori fotochimici. Interazioni
luce-materia: nozioni di spettroscopia elettronica, assorbimento ed
emissione di radiazioni, relazioni tra le quantità teoriche e quelle
sperimentali. Tipi di transizioni in molecole organiche. Natura degli
stati elettronici eccitati e processi fotofisici di decadimento.
Parametri cinetici e rese quantiche. Processi monomolecolari e
bimolecolari di decadimento degli stati eccitati. Processi di
decadimento radiativi (fluorescenza e fosforescenza) ed applicazioni in
analisi chimica quantitativa. Saggi fluoimmunologici. Metodologie ELISA
in assorbimento ed emissione. Principi di funzionamento ed applicazioni
dei laser. Applicazioni dei laser in chimica analitica: tecniche LIDAR
e DOAS. Rassegna, descrizione ed analisi di alcune applicazioni
tecnologiche della fotochimica (fosfori inorganici, fotocromismo,
sintesi organica, fotopolimerizzazione e fotoreticolazione,
fotosensibilizzazione e fotodegradazione, chemiluminescenza e
fotocatalisi. Trasformazione e conservazione dell?energia solare:
biomasse, pannelli solari a bassa temperatura, solare termodinamico,
solare fotovoltaico e metodologie per la fotolisi dell?acqua.
Fotosintesi. Effetti delle radiazioni sui sistemi biologici. Processi
di fotosensibilizzazione di farmaci. Intercalazione di farmaci e
coloranti nel DNA: metodi per la caratterizzazione dei complessi ed
effetti fotochimici.
|
| |
Modalità di Esame:
Esame
|
| |
Orario di Ricevimento:
Martedì 9-11, Giovedì 16-19
|
| |
Testi Consigliati:
|
|
|
Chimica informatica ambientale
|
|
(Docente:
Prof.
CRUCIANI
Gabriele)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
1. Introduzione al corso
1.1 modelli matematici globali e locali
1.2 la statistica multivariata per il trattamento dati
1.3 modelli matematico-statistici
2. Fondamenti di modellistica ambientale
2.1 i modelli molecolari
2.2 la necessita' di stimare le proprieta' molecolari
2.3 il calcolo dei descrittori dei composti chimici
2.4 la stima delle proprieta' dei composti chimici
3. La predizione dell'impatto ambientale
3.1 predizione della ripartizione tra fasi
3.2 ripartizione tra bio-fasi
3.3 trasporto tra fasi bio-organiche
4. La tossicita' dei composti chimici
4.1 tossicita' aspecifica e specifica
4.2 tossicita' nell'uomo e negli animali
4.3 predizione della tossicita'
|
| |
Modalità di Esame:
Esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Tutti i giorni
|
| |
Testi Consigliati:
Dispense del docente
|
|
|
Chimica inorganica applicata
|
|
(Docente:
Prof.
CROCCHIANTI
Stefano)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
no
|
| |
Programma:
Origine della scienza nucleare.
Costituzione del nucleo atomico.
Decadimenti.
Stabilita` dei nuclidi.
Interazione radiazione-materia.
Rivelazione e misurazione.
Reazioni nucleari.
Radiochimica ambientale.
|
| |
Modalità di Esame:
esame orale.
|
| |
Orario di Ricevimento:
14-15
|
| |
Testi Consigliati:
|
|
|
Chimica organica
|
|
(Docente:
Prof.ssa
PIERMATTI
Oriana)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
Richiede: Chimica Generale
|
| |
Programma:
La chimica organica e la vita. Ibridazione del carbonio. I legami
chimici. Interazioni intermolecolari. Principi di stereochimica.
Analisi conformazionale. Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e
principali reazioni chimiche delle più importanti classi di composti
organici. Alcani: combustione ed alogenazione. Alcheni e alchini:
reazioni di addizione. Alogenuri alchili: reazioni di sostituzione ed
eliminazione. Il benzene e l'aromaticità: reazioni di sostituzione
elettrofila aromatica. Alcoli, fenoli e tioli. Eteri ed epossidi.
Aldeidi e chetoni: addizione nucleofila, reazioni al carbonio alfa;.
Acidi carbossilici: sostituzione nucleofila acilica. Derivati degli
acidi carbossilici: cloruri acilici, esteri, ammidi ed anidridi.
Ammine. Chetoacidi, chetoesteri, composti dicarbonilici: sintesi
malonica e acetoacetica. Composti eterociclici con anelli a cinque e
sei atomi: pirrolo, furano, tiofene, imidazolo e piridina. Composti
naturali contenenti anelli eterociclici. Lipidi. Carboidrati.
Amminoacidi. Proteine. |
| |
Modalità di Esame:
Esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
lunedì ore 11-13
|
| |
Testi Consigliati:
J. McMurry
Chimica Organica
Zanichelli
|
|
|
Chimica organica - Laboratorio di chimica organica |
|
(Docente:
Prof.ssa
PIERMATTI
Oriana)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
Richiesta: Chimica Generale
|
| |
Programma:
Parte teorica
Prevenzione e sicurezza nel laboratorio di chimica. Classificazione
delle sostanze chimiche in base alla loro pericolosità. Pronto
soccorso. Vetreria di laboratorio.
Tecniche di base per la separazione e purificazione dei composti chimici:
a. Filtrazione per gravità e sotto vuoto
b. Cristallizzazione: essiccamento dei cristalli. Il punto di fusione
c. Estrazione con solventi
d. Distillazione: semplice e frazionata; a pressione atmosferica e sotto vuoto. Distillazione in corrente di vapore
e. Cromatografia di adsorbimento e di ripartizione: cromatografia
su carta , su strato sottile, su colonna. Cenni di Gas-cromatografia e
di cromatografia ad alte pressioni.
Identificazione spettroscopica delle strutture di composti organici:
a. Spettroscopia di massa
b. Spettroscopia infrarosso (IR)
c. Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare protonica (1H-NMR)
Letteratura chimica e ricerca bibliografica
Parte sperimentale
Vengono eseguite 7-8 esperienze pratiche riguardanti la
preparazione di composti organici e successiva purificazione e
caratterizzazione chimico fisica e spettroscopica. |
| |
Modalità di Esame:
Prova Scritta
|
| |
Orario di Ricevimento:
lunedì ore 15-17
|
| |
Testi Consigliati:
H. Hart, L. E. Craine; Laboratorio di Chimica Organica, Zanichelli
R. M. Roberts, J. C. Gilbert, S. F. Martin; Chimica Organica Sperimentale, Zanichelli
|
|
|
Chimica organica applicata - Aspetti chimici, applicazioni, riciclo di materiali polimerici |
|
(Docente:
Dott.ssa
MARROCCHI
Assunta)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
Il corso non richiede propedeuticità formali; si consiglia comunque la
conoscenza degli elementi forniti nel corso di Chimica Organica |
| |
Programma:
Polimeri sintetici. Classificazione. Meccanismi di polimerizzazione: polimerizzazione radicalica,
anionica, cationica. Polimerizzazioni ad apertura di anello. Polimerizzazione di Ziegler-Natta.
Polimerizzazione dei dieni. Copolimeri. Resine epossidiche. Polimeri termoplastici, termoindurenti,
orientati. Polimeri biodegradabili. Applicazione dei polimeri nel restauro e conservazione dei Beni
Culturali ed in campo biomedico. Recupero e riciclo di materiali polimerici: riciclo meccanico, riciclo
chimico, termovalorizzazione. Processi chemolitici:
alcolisi/idrolisi di poliesteri, poliammidi,poliacetali, a nuovi
prodotti per la polimerizzazione. Processi termolitici. Discussione
dettagliata del
riciclo del PET e del PVC
|
| |
Modalità di Esame:
Esame. Prova:orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Mer 11.00-13.00; Gio 11.00-13.00
|
| |
Testi Consigliati:
Dispense del docente
|
|
|
Chimica organica applicata
|
|
(Docente:
Prof.
TATICCHI
Aldo)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
Il corso non richiede propedeuticità; si consiglia comunque la
conoscenza degli elementi forniti nel corso di Chimica Organica |
| |
Programma:
Petrolio: origine e composizione. Distillazione frazionata. Benzine. Craking termico e catalitico.
Reforming catalitico. Gas naturale. Carbone. Combustione e relativi problemi ambientali. Raffinazione
prodotti petroliferi: idrosolforazione, catalizzatori e reazioni di desolforazione. Effetto serra e
riscaldamento globale del pianeta. Protocollo di Kyoto. Direttive europee: emission trading, joint
implementation, clean development mechanism.
Atmosfera: composizione. Inquinanti atmosferici. Smog fotochimico. Emissioni dei veicoli. Ossidi di
zolfo e azoto. Particolato.
Origine, reazioni e tossicità di IPA, PCB, PCDD, PCDF. Metalli pesanti e chimica del suolo.
|
| |
Modalità di Esame:
Esame. Prova: orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
sempre disponibile
|
| |
Testi Consigliati:
Consultare il docente
|
|
|
Ecotossicologia
|
|
(Docente:
Dott.ssa
ELIA
Antonia Concetta)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
Programma:
Tossicologia classica, ambientale ed ecotossicologia: metodi, strategie e obiettivi
Struttura e funzioni dei sistemi naturali: ecologia descrittiva e
ecologia funzionale. Studio di un popolamento lacustre: fitoplancton e
zooplancton.
Studio degli effetti dei contaminanti sui sistemi biologici: tossicità acuta e subacuta; saggi di
tossicità: protocollo dello studio tossicologico
Principali classi di contaminanti chimici e loro ripartizione nei
vari comparti ambientali Bioconcentrazione, bioaccumulo,
biomagnificazione e processi di degradazione
Strumenti predittivi per la stima della tossicità. Vantaggi e limiti degli approcci QSAR (relazioni
quantitative struttura-attività biologica)
Criteri di qualità ambientale
Indicatori biologici. Criteri di scelta. Individui e popolazioni come indicatori; struttura della
comunità e cambiamenti funzionali come indicatori. Indicatori di bioaccumulo
Biomarkers come strumenti diagnostici e prognostici di salute ambientale
Il biomonitoraggio nel controllo e gestione della qualità dell?ambiente
Rischio ambientale: identificazione e caratterizzazione del pericolo; valutazione dell?esposizione;
caratterizzazione e gestione del rischio
Contributo dell?ecotossicologia nei processi decisionali per la salvaguardia della salute ambientale
Esempi di applicazioni ecotossicologiche negli ambienti acquatici
|
| |
Modalità di Esame:
esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Mercoledì ore 11-13
|
| |
Testi Consigliati:
M. VIGHI, E. BACCI 1998. Ecotossicologia. UTET, Torino
|
|
|
Geochimica Applicata
|
|
(Docente:
Dott.
FRONDINI
Francesco)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
Programma:
|
| |
Modalità di Esame:
|
| |
Orario di Ricevimento:
|
| |
Testi Consigliati:
|
|
|
Tecnologie chimiche per l'ambiente - Laboratorio di chimica ambientale |
|
(Docente:
Prof.
CLEMENTI
Sergio)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
Campionamento e preparazione dei campioni ambientali prima dell?analisi
strumentale: apparecchiature per il campionamento di matrici ambientali
solide, liquide ed aereoformi, tecniche di prelievo dei campioni,
conservazione, trasporto e stoccaggio dei campioni; condizionamento dei
recipienti in funzione dell?analita determinato e scelta dei materiali;
tecniche di mineralizzazione, estrazione e preconcentrazione dei
campioni.
Applicazione di tecniche spettroscopiche e cromatografiche all?analisi di campioni ambientali.
Esercitazioni in campo e in laboratorio esemplificative delle varie
tecniche di campionamento, trattamento ed analisi di matrici
ambientali.
|
| |
Modalità di Esame:
Esame orale
|
| |
Orario di Ricevimento:
Lun-Ven 9.00-12.00
|
| |
Testi Consigliati:
Appunti del docente
|
|
|
Tecnologie chimiche per l'ambiente
|
|
(Docente:
Prof.
POLETTI
Antonio)
|
| |
|
Periodo didattico:
II semestre
|
| |
Programma:
Termodinamica ambientale
LACA. Tecniche di utilizzo di biomasse per uso energetico
Compostaggio
tecniche abbattimento odori
|
| |
Modalità di Esame:
Esame
|
| |
Orario di Ricevimento:
lunedi 11,30-13,30 martedì 11,30-13,30
|
| |
Testi Consigliati:
Dispense del docente
|
|
|
Tecnologie di monitoraggio ambientale
|
|
(Docente:
Dott.
PROIETTI
Gabriele)
|
| |
|
Periodo didattico:
I semestre
|
| |
|
Propedeuticità:
propedeutico
|
| |
Programma:
? Cenni introduttivi alla variabilità chimico-fisica di una matrice naturale.
? Analisi puntiforme singola. Mono/multi analisi. Analisi ripetuta
a frequenza temporale e analisi ripetuta nel tempo e nello spazio
contestuale ecosistemico: Monitoraggio chimico.
? Monitoraggio chimico, definizione in relazione agli obiettivi.
? Metodi e tecnologie di monitoraggio tramite misura di indicatori ambientali secondo le direttive della EEA, WHO, OECD, UNCHS.
? Indicatori chimici ambientali : macrodescrittori, microdescrittori, trasduttori.
? Classificazione degli indicatori:
- Parametri chimico-fisici generali obbligatori: Temperaruta,
Conducibilità, O2 disciolto, pH, BOD, COD, altri parametri obbligatori
per comparto idrico;
- Indicatori inorganici ( Anioni, Cationi, Metalli a priorità alta);
- Indicatori organici: VOC?s, BTeX?s, ClP?s, PCT?s, PCB?s, PAH?s, PCDD?s, PCDF?s, altri POP?s a priorità elevata;
- Indicatori secondo le direttive della EEA, OECD, UNCHS .
? Caratteristiche degli indicatori di comparto a funzione logica
causa-effetto: scelta, significatività, rappresentatività,
affidabilità, misurabilità e relativi principi teorici di misura (GC,
LC, IEC, PSA, AAS-GF, ICP).
? Indicatori chimici misurabili in modalità discontinua e in modalità on-line/auto-manual.
? Impianto di monitoraggio: Analisi chimica di laboratorio su
matrici naturali campionate. Analisi in modalità local a gestione auto
/manual, analisi on-line a gestione local/remote - manual / auto.
? Panoramica delle tipologie di monitoraggio:
- Monitoraggio discontinuo e on line di Indicatori del comparto acque e aria.
- Telemonitoraggio di parametri chimico fisici e indicatori organici totali in contesto urbano ? regionale ? nazionale: cenni.
- Monitoraggio indiretto: Biomonitoraggio per la valutazione di
indicatori trasduttori e biodiversità nel comparto idrico (cenni
introduttivi al metodo dei Biomarker).
? Introduzione al protocollo di sviluppo di un impianto di
monitoraggio coerente secondo fasi operative: conoscenza sito di esame
? scelta dei comparti e degli indicatori significativi - impianto
analitico strumentale.
? Esempi di programmi di monitoraggio realizzati a dimensione
regionale per sistemi lacustri e fluviali. Esempi di impianti di
monitoraggio per per la qualificazione di un sito ambientale. Cenni ad
applicazioni del metodo dei Biomarker sviluppate a dimensione locale.
|
| |
Modalità di Esame:
esame
|
| |
Orario di Ricevimento:
lunedì , martedi ore 9.00 - 11,00
|
| |
Testi Consigliati:
Dispense e documenti ufficiali APAT.
|
|
|
RECAPITI DEI DOCENTI |
|
|
Prof.
ALOISI
Gian Gaetano
|
aloisi@unipg.it |
5574 |
|
Prof.
BALESTRIERI
Fabrizio
|
balestra@unipg.it |
5215 |
|
Prof.
BELLACHIOMA
Gianfranco
|
bellach@unipg.it |
5577 |
|
Prof.
CLEMENTI
Sergio
|
sergio@chemiome.chm.unipg.it |
5613 |
|
Prof.
CROCCHIANTI
Stefano
|
croc@dyn.unipg.it |
5515 |
|
Prof.
CRUCIANI
Gabriele
|
gabri@chemiome.chm.unipg.it |
5629-5550 |
|
Dott.ssa
DEL GIACCO
Tiziana
|
dgiacco@unipg.it |
5559 |
|
Dott.ssa
ELIA
Antonia Concetta
|
elia@unipg.it |
5717 |
|
Dott.
FRONDINI
Francesco
|
frondini@unipg.it |
2618 |
|
Dott.ssa
MARROCCHI
Assunta
|
assunta@unipg.it |
5547 |
|
Prof.
MURGIA
Sandro Maria
|
murgia@unipg.it |
5583 |
|
Dott.
ORTICA
Fausto
|
ortica@unipg.it |
5576 |
|
Prof.
PALMERINI
Carlo Alberto
|
crlpal@unipg.it |
7444 |
|
Prof.ssa
PIERMATTI
Oriana
|
oriana@unipg.it |
5559 |
|
Prof.
POLETTI
Antonio
|
poletti@unipg.it |
5584-5595 |
|
Dott.
PROIETTI
Gabriele
|
gproietti@unipg.it |
5138 |
|
Dott.
ROMANI
Aldo
|
romani@unipg.it |
5620 |
|
Prof.
TATICCHI
Aldo
|
taticchi@unipg.it |
5537-5547 |
|
 STAMPA STAMPA
|
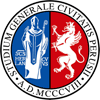
 Laurea triennale
- T068
- Chimica ambientale
Laurea triennale
- T068
- Chimica ambientale
 STAMPA
STAMPA